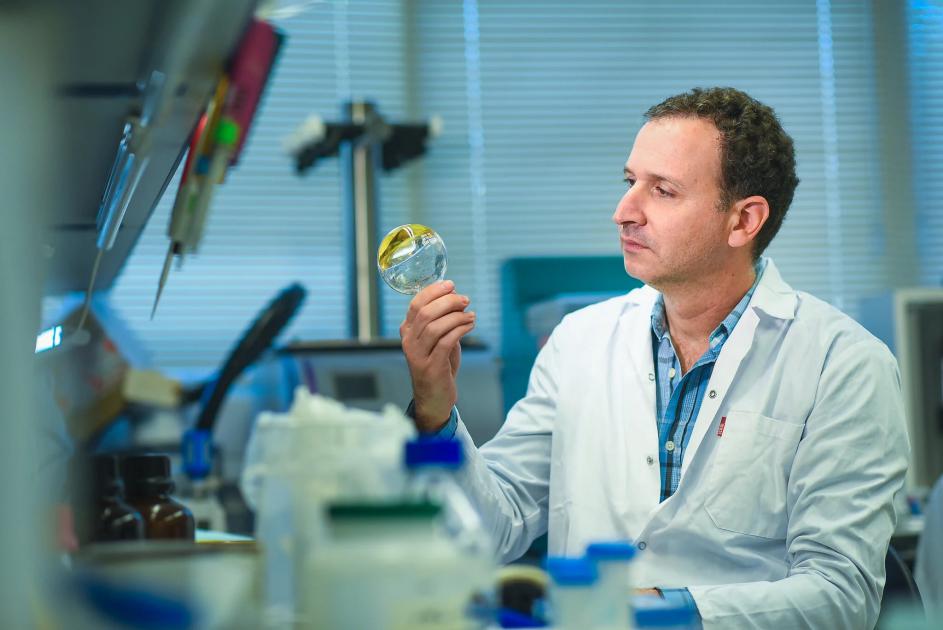Un viaggio di lavoro utile
Il senso generale del viaggio a Washington di Bibi Netanyahu, che è durato quasi tutta la settimana scorsa con numerosi incontri con i maggiori dirigenti americani e ben due colloqui riservati con Trump, è evidente: il coordinamento con gli Usa è fondamentale per lo stato ebraico ed è anche da sempre uno degli impegni personali del primo ministro. Netanyahu è particolarmente competente in questi rapporti, essendo il politico israeliano che conosce meglio gli Usa: ha vissuto in America per una dozzina di anni, prima da ragazzo, poi studiando al MIT e poi ottenendo il dottorato a Harvard, facendo infine il rappresentante di Israele all’Onu nel periodo fra la sua brillante carriera militare e l’inizio della vita politica. Da primo ministro l’ha visitata decine di volte, parlando spesso al Congresso e incontrando tutti i protagonisti politici ed economici. La sua conoscenza dei meccanismi politici e dei protagonisti della vita pubblica di Washington gli ha permesso di esercitarvi da sempre un’influenza unica, sia durante le presidenze amiche come questa, sia quando l’amministrazione non aveva nessuna simpatia per Israele, come durante l’epoca di Obama. Questo viaggio, tenuto appositamente un po’ nascosto ai media, gli è servito non solo ad incontrare il presidente, ma anche a sondare e cercare di influenzare rappresentanti dell’amministrazione e del Congresso.
Le ragioni del viaggio
Ma perché il leader di una nazione in guerra, che deve gestire una maggioranza di governo traballante, l’ostilità del sistema giudiziario e a quanto pare anche il dissenso dello stato maggiore delle forze armate sulla gestione della guerra a Gaza, decide di dover restare all’estero tanto a lungo, senza che emergano decisioni nuove? Certamente i colloqui si sono incentrati su tre temi: l’Iran, per precedere la possibilità ammessa da Trump che Israele (ma non l’America) possa riprendere i bombardamenti se interverranno indizi di lavori per recuperare il progetto nucleare; la via per realizzare un nuovo Medio Oriente in pace con Israele e aperto al progresso economico e sociale; gli sviluppi della campagna di Gaza. Su questo punto probabilmente c’è stata la maggior necessità di discutere per coordinare la posizioni ed eliminare malintesi.
È possibile il negoziato?
Trump vuole la fine della guerra di Gaza e la liberazione degli ostaggi, l’ha detto molte volte e ha spesso annunciato il progresso delle trattative con Hamas. Netanyahu è molto meno ottimista, anche se accetta l’idea di un cessate il fuoco per riavere almeno alcuni dei rapiti. Ma, probabilmente, è convinto che Hamas non li libererà tutti se non in cambio della sua sopravvivenza come forza armata e dominante a Gaza, in futuro anche nei territori amministrati dall’Autorità Palestinese, dove ha il consenso della maggioranza degli arabi e Muhamed Abbas è troppo vecchio e malato per poter tenere a lungo il potere.
Le difficoltà di una presa completa di Gaza
La soluzione più ovvia per Israele sarebbe occupare tutta la Striscia e distruggere quel che resta dell’organizzazione e dell’infrastruttura terroristica, dopo aver già eliminato quasi tutti i suoi capi, moltissimi uomini e mezzi. Ma ci sono tre ostacoli. Il primo è ben noto, la protezione che tutta la sinistra occidentale, buona parte dei governi e dei media europei e conseguentemente l’opinione pubblica hanno accordato ai terroristi di Gaza, sotto ipocriti pretesti umanitari. La seconda, in genere meno considerata, è il fatto che Hamas, per ragioni ideologiche ma anche pratiche (il suo dominio sugli aiuti alimentari, che le organizzazioni internazionali continuano in sostanza a delegargli), conserva un forte controllo della popolazione ed è in grado di mobilitare se non quadri di alto livello tecnico, almeno numerosi attentatori come quelli che hanno inferto gravi danni nelle ultime settimane alle truppe israeliane, in un inatteso soprassalto di aggressività. La terza, emersa di recente, è la resistenza dello stato maggiore delle forze armate, anche sotto la nuova direzione di Zamir, e a entrare finalmente nelle zone più pesantemente presidiate da Hamas nel centro di Gaza e a occuparle, con la motivazione che in questa maniera si metterebbe a rischio la vita dei rapiti e si costringerebbe l’esercito ad amministrare la vita di due milioni di arabi, mettendolo in pericolo e danneggiando le sue capacità di combattimento.
La possibilità dei negoziati
Netanyahu potrebbe dunque dover tentare di ottenere con la trattativa quei risultati che è difficile ottenere oggi con un’occupazione militare. Nessuno può dire che questo sia il suo piano, o se invece la trattativa sia solo una diversione tattica per convincere Trump (e Zamir) che l’occupazione di Gaza è inevitabile. È probabile che si tenga aperte le due strade. Anche perché il negoziato può funzionare, come si è visto in Libano quando un cessate il fuoco, da molti percepito come un’imposizione americana che impediva di “portare fino in fondo la guerra”, ha prodotto il primo governo da decenni che sta cercando di disarmare Hamas e osa parlare di pace con Israele. Nel quadro rientra anche il fatto che i partiti di destra del governo non vogliono sentir parlare di trattative e minacciano dimissioni (come peraltro anche gli charedim che non riescono a ottenere la legge sulla leva che esenti i loro studenti). La maggioranza insomma è a rischio. Ma il sistema politico israeliano non ammette la caduta del governo senza un passaggio in Parlamento e da fine mese fino a tutto ottobre le sessioni sono sospese. Dunque Netanyahu deve temporeggiare un paio di settimane per condurre quest’estate nella pienezza dei poteri del governo di guerra l’azione diplomatica o militare che riterrà opportuna e che probabilmente ha concordato con Trump. A quanto pare, ha proposto nel negoziato una mappa circolata sui media in cui durante il cessate il fuoco continuerà la presenza dell’esercito israeliano per la profondità di un paio di chilometri su tutti i bordi di Gaza e soprattutto al Sud, dove in uno spazio sicuro senza presenza terrorista Israele vuole continuare la fondamentale gestione degli aiuti alimentari attraverso la fondazione americana saltando la mediazione di Hamas, che procura fondi e potere ai terroristi. La proposta come prevedibile è stata rifiutata anche per questa ragione, ma probabilmente era solo un ballon d’essai.
Una nuova struttura tribale?
Fra i vari dati strategici ve ne sono diversi positivi. Il primo è che l’azione segreta continua a colpire i vertici politici, militari e scientifici (cioè atomici) dell’Iran, dove per il momento non vi sono segni di recupero dei materiali nucleari danneggiati nei bombardamenti. La seconda è che non solo tiene duro contro le intimidazioni di Hamas il gruppo armato tribale che si è costituito intorno ai centri di distribuzione americana di aiuti, ma vi è stata un’importante dichiarazione di numerosi capi tribali di Hebron in cui si proponeva a Israele la costituzione in quella città di un emirato indipendente dall’Autorità Palestinese, aderente agli accordi di Abramo e in pace con Israele. Se la riemersione della struttura tribale profondamente iscritta nella cultura araba riuscisse a spezzare i meccanismi tradizionali di rivendicazione di uno “stato di Palestina”, i giochi politici della regione cambierebbero profondamente e ci potrebbe profilarsi davvero una nuova via per la pace.