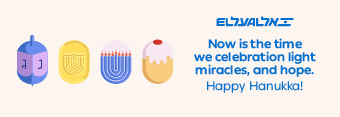La primavera del 1967 sembrava tranquilla, in Europa. Non accadeva proprio nulla di nulla, e la guerra fredda si trascinava stancamente mentre pochi scrutavano il cielo per scoprire se l’attimo della guerra nucleare sarebbe stato il successivo. Roma era probabilmente la città più sonnolenta del pianeta, e c’era chi trascorreva le domeniche a Fiumicino per vedere decolli e atterraggi dei jet dalla terrazza dell’unico terminal esistente Quello era Ciampino bis e dunque un po’ più grande, e sicuramente migliore perché a un passo dal mare. Il nuovo millennio appariva così lontano da far ritenere che nessuno, benché nell’adolescenza o nella prima giovinezza, sarebbe riuscito a stappare la bottiglia di mezzanotte alla fine del 1999. Gli anni ‘60 scivolavano lenti. Il presente era fortissimo, e la modernità arrancava a quattro ruote, senza l’aria condizionata, sui nastri d’asfalto arroventati di luglio e d’agosto, e sulle prime sfiatate autoradio che sibilavano allegramente le note di festivalbar e dischi per l’estate grazie a microfrazioni di watt. L’alta fedeltà era solo un’etichetta per i costosissimi 33 giri della musica classica. Alla fine di marzo di quell’anno, il 1967, altrimenti dimenticato, un tiranno in crisi di popolarità volle salire di nuovo sul palcoscenico e prendersi la scena. Decise dunque di imporre all’ONU il ritiro delle forze di interdizione che dal 1957 presidiavano il Sinai egiziano. Il 22 maggio comunicò al mondo l’intenzione di chiudere lo sconosciuto Stretto di Tiran a tutte le navi dirette al porto israeliano di Eilat. Senza la mossa d’azzardo del presidente Gamal Abdel Nasser, l’unico credibile pretesto grazie al quale oggi potremmo ragionevolmente discutere del 1967 riguarderebbe i fatti, indiscutibili, della cronologia, e dunque le sottili ragioni matematiche cui attribuire la sola responsabilità del 67: quella di precedere il 68. E così, mentre le radio della R.A.U. (Repubblica Araba Unita di Siria ed Egitto) diffondevano la promessa di annegare Israele nel mare dal quale erano arrivate le navi di Exodus, molti giovani in Italia, in Francia, in Gran Bretagna si trovarono condannati a riscoprire un’identità tradizionale, ingombrante, tollerata e talvolta anche apprezzata purché rigorosamente non altra e non diversa: ma solo nei giorni delle celebrazioni del Victory-Day Europe, l’indimenticabile 8 maggio 1945, qui da noi anticipato al 25 aprile. Il presidente egiziano aveva realizzato il progetto antisionista-antiebraico di confederare l’Egitto e la Siria, con l’aiuto di non pochi criminali di guerra nazisti espatriati nel suo accogliente reame. Prometteva guerra totale. Ma invece la Guerra dei Sei Giorni avrebbe portato a Israele una vittoria rapida, inaspettata. Le conseguenze si prolungarono nel tempo. Fino ad oggi. Anche la Giordania fu coinvolta nei combattimenti, e il regno del giovane Hussein si trovò privato dei territori ad ovest del fiume Giordano che aveva occupato nel 1949, insieme con la Città Vecchia di Gerusalemme. Su quelle poche migliaia di chilometri quadrati, che da allora sono divenuti per definizione “i territori occupati”, oltre un milione di arabi palestinesi entrò di colpo nel conflitto più arroventato e più simbolico della storia contemporanea: faccia a faccia, giorno dopo giorno, con gli ebrei d’Israele. Da 1948 al 1967 s’era vista infatti una classica situazione di belligeranza tra Stati sovrani lungo la cosiddetta “linea verde”. Con la fine di giugno la “linea verde” cessò di esistere. Più a sud, a Gaza e dunque nella città dei fatti di Dalila e Sansone, altre centinaia di migliaia di palestinesi conobbero, prima ancora dell’esercito israeliano, il proletariato della grande periferia di Tel Aviv. Fino ai primi anni ’70 a Gaza si andava per comprare ortaggi a buon mercato. Un risparmio che a qualche cliente costò la vita. Ed era infatti a Gaza che nel 1949 l’Egitto del re Faruk, in seguito protagonista della “dolce vita” romana, aveva segregato alcune centinaia di migliaia di arabi palestinesi. In Europa e negli Stati Uniti, dotti e stimati professori di illustri università spiegavano, senza vergogna, che i sionisti avevano trasformato il mite ebreo dei ghetti nel prussiano del Medio Oriente. Furono ben ascoltati anche da giornali autorevoli. All’improvviso tutti si diedero al tifo più fantasioso mai apparso prima sugli spalti della grande politica internazionale: tutti contro il vero “lupo” –lo Stato di Israele e gli ebrei che lo consideravano la sola affidabile polizza di assicurazione sulla propria vita– e tutti a favore del povero “agnello”, il mondo arabo. Una fiaba moderna, invenzione di allora che sopravvive ancora oggi. Da qualche anno questa ed altre banalità sono entrate a far parte, a pieno titolo, del grande repertorio di ciò che chiamiamo “stupidità di sinistra”, ovviamente la più dannosa e pericolosa. Prosperavano allora i comunisti dei vecchi tempi dell’Unione Sovietica e della guerra fredda. E gli ebrei, i giovani in particolare, erano tutti comunisti. E come poteva essere diversamente? I partigiani e gli ebrei, stessi rischi e stessa lotta. Stesso 8 maggio –Victory Day– e stesso 25 aprile. I comunisti avevano dato un contributo decisivo alla disfatta del nazifascismo. Però adesso il sistema sovietico stava dalla parte degli arabi, contro il “cosmopolitismo sionista, agente dell’imperialismo”. Questa terminologia rappresentava benissimo la scorciatoia lessicale utilizzata per nascondere il più tradizionale antisemitismo. E anche sull’altro fronte della guerra fredda, in occidente, pochi avevano graziato gli ebrei col balsamo storico dell’oblio e del silenzio. La presunzione di colpa continuava a prevalere su quella d’innocenza. Gli anni terribili dal 1933 al 1945 avevano incoraggiato un periodo di benevolenza. Ma questa benevolenza stava diventando qualcos’altro. La fondazione di uno Stato ebraico sembrava davvero aver chiuso una contabilità storica di pura perdita. Schierarsi accanto agli stati arabi dei dittatori e del petrolio significava conciliare dipendenza energetica e finto terzomondismo dei venditori di armi. In Europa, e qui in Italia, il solo visibile risultato degli eventi mediorientali del 1967 fu che al ’68 mancarono alcune migliaia di militanti ebrei. Ci si era illusi di essere considerati uguali per davvero, ci aveva confortato la speranza di essere talmente uguali che gli altri avrebbero finalmente sopportato la nostra differenza, per quel poco che pure ne restava. Ancora oggi, vengono accettate con facilità progressista tutte le differenze più o meno alla moda, tranne quella ebraica. In quel giugno del 1967 l’Europa e il mondo dovettero dunque accorgersi con fastidio che per un imprevedibile incidente della storia un certo numero di ebrei avevano creato una piccola nazione-rifugio sulla sponda orientale del Mediterraneo. Quella nazione, in bene molto e un poco anche in male come tutte le cose umane, si trasformò dopo i Sei Giorni di giugno 1967 nello Stato di Israele così come è oggi. Unica vera democrazia del vicino oriente, resistente al Covid19 e ai missili di Hamas, economia solida e all’avanguardia nelle tecnologie, insostituibile polizza di assicurazione sulle vite ebraiche.