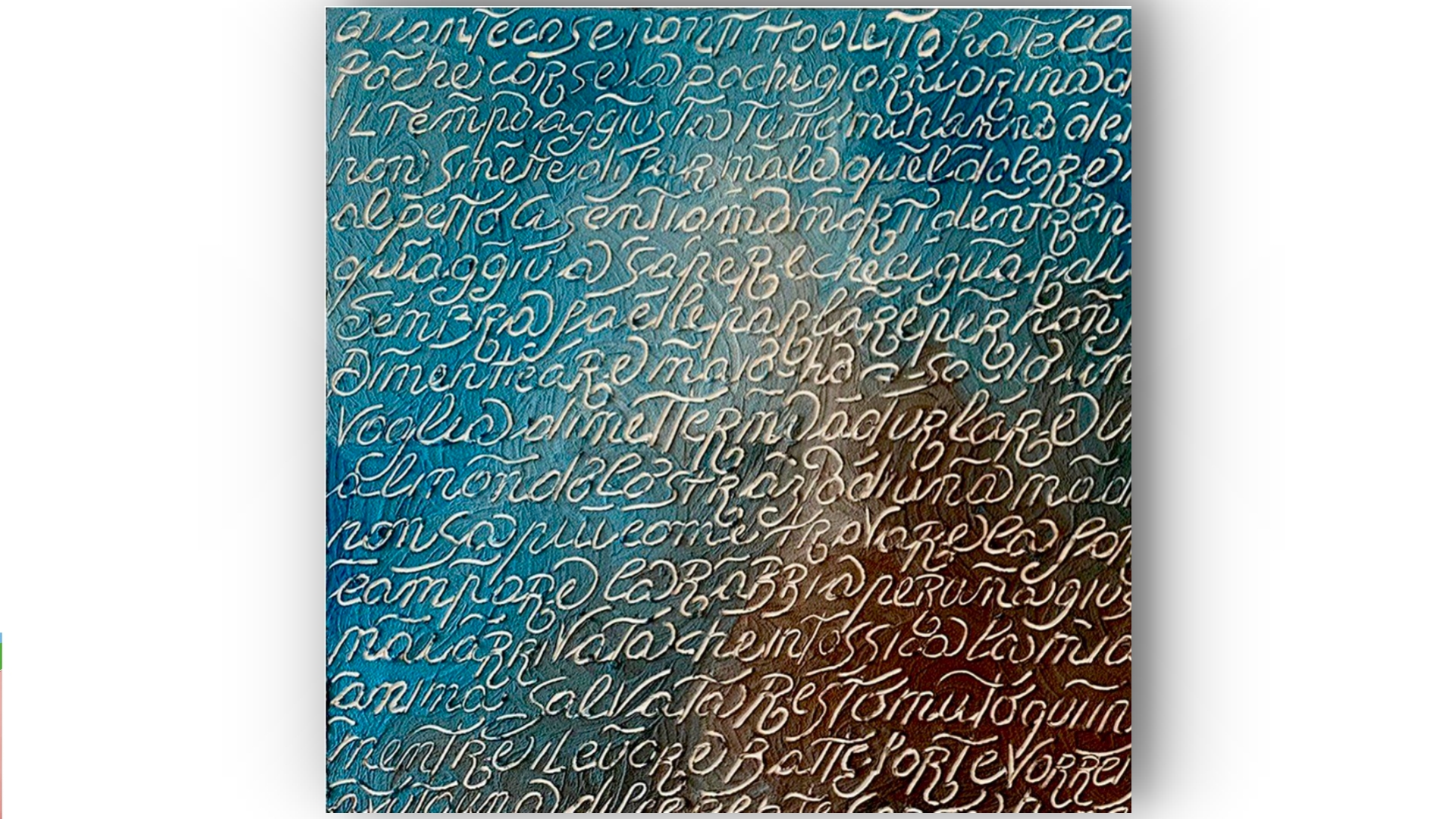Roma 9 ottobre 1982. Perdonatemi, mi sto ripetendo. Ma veramente mi è successo così. Nel momento in cui sono ritornata con il pensiero a quel giorno di ormai quarant’anni fa mi si è presentata, come se fosse l’unica possibile, come se non si potesse o dovesse cercare altro, la stessa identica formulazione dello Shalom di allora.
Un luogo, un mese, un anno. In quel luogo, quel mese e quell’anno, Roma ebraica era stata oggetto di una strage che aveva lasciato a terra decine di feriti e condannato a morte un bambino di appena due anni. Come si poteva ricorrere, dopo questa lacerazione, alle espressioni del nostro linguaggio quotidiano? Sarebbe suonato incongruo. Quasi una profanazione. Le parole dell’essere umano sono soltanto briciole al vento quando sconcerto e dolore si sono rappresi in un unico masso. È di fronte a questo masso impenetrabile che ti devi fermare con rispetto.
Dopo, certamente, affrontare la realtà diventa “dovere etico”. Agisci, ti muovi, urli la tua indignazione. Ma quel primo silenzio è lì a riaffiorare ancora nei momenti più strazianti come, per tutti gli ebrei di Roma, quello del funerale del piccolo Stefano Taché, seguito dalla marcia muta e silente dei movimenti giovanili ebraici per le strade della città.
Ecco, io mi sono ritrovata in questo stesso tumulto fra blocco e sensazioni a contrasto, quando Ariela Piattelli, direttore dello Shalom attuale, ha chiesto a me, direttore di allora di rievocare qualche ricordo personale di quei giorni funesti.
Sì, qualche tassello di quel tragico copione lo posso sicuramente aggiungere ma non ho potuto fare a meno di partire da quel masso che tale è rimasto.
Il mio tassello, forse, ha a che fare con il punto di vista di una testimone che si presenta con una duplice e sovrapposta situazione personale: quella di una madre che ha visto tra i feriti un figlio e la sua ragazza e la funzione di una giornalista, costretta ad affrontare, con più competenza e distacco possibile, il ruolo che le compete.
L’atmosfera che in quel 1982 aleggiava nei confronti degli ebrei in Italia era pesante.
L’operazione dell’esercito israeliano in Libano che, sotto certi aspetti, era stata discussa e a volte contestata anche negli ambienti ebraici, si era trasformata in una campagna di odio che puntava diritto sugli ebrei della diaspora. Tutti i canoni del più feroce antisemitismo parevano esser stati resuscitati. In quella rinnovata forma di Inquisizione, la richiesta che si poneva a ogni ebreo era più o meno quella di render pubblica la propria presa di distanza dallo Stato ebraico.
“Non si vergogna di essere ebreo Gillo Pontecorvo?” titolava nel suo numero del 9 ottobre il rotocalco femminile “Amica”, mentre i nostri studenti nelle scuole e i militanti nei partiti politici venivano strattonati da un continuo, martellante, ricatto cosiddetto “morale”.
Meno noto e forse meno rilevante (ma non troppo) è quello che è capitato a noi di Shalom.
Il proprietario della tipografia ci ha chiamati un giorno per comunicarci, con artefatta compunzione, che le maestranze si sarebbero rifiutate di stampare il numero di settembre se non avessimo accettato di pubblicare in prima pagina un loro comunicato di dura condanna nei confronti dello Stato ebraico. Non fare uscire Shalom proprio nel momento in cui, sia pure nei suoi limiti, poteva farsi portavoce dell’urlo di protesta della vessata comunità ebraica? Confesso che, tormentata da questo angoscioso dilemma, ho provato a proporre agli altri redattori un nostro acuminato contro-comunicato a chiosa di quello impostoci dalla tipografia. Ma Luciano Tas ha battuto un pugno sul tavolo, gridando: “NO! Noi non pubblicheremo nessun comunicato”. Aveva avuto ragione. Niente comunicati, che fossero dei tipografi o nostre riparazioni. E il numero era uscito lo stesso.
Ma altro si era dovuto sopportare a più vasto raggio. Arafat, il capo dell’organizzazione terroristica che, anni prima, aveva rivendicato con orgoglio l’attentato alle Olimpiadi di Monaco e l’eccidio dei bambini della scuola israeliana di Maalot, era stato ricevuto con enfatici onori dalle massime autorità dello Stato italiano e anche dal Papa. Aveva preso le distanze dal suo passato? Se sì, si sarebbe potuto dialogare con lui. Ma onorarlo? Il colpo di grazia di questo precipitare nel male era stato, come tutti sanno, la macabra iniziativa da parte dei partecipanti di un corteo sindacale di deporre una bara davanti alla lapide dei deportati affissa al Tempio Maggiore.
Erano cose orribili. Il clima diventava sempre più soffocante. Io le ho qui ricordate solo per sottolineare come, malgrado tutto (malgrado tutto) nessuno era riuscito a immaginare che veramente negli stessi luoghi che nel 1943 avevano fatto da tragico sfondo alla deportazione degli ebrei romani, proprio lì altri ebrei romaniavrebbero incontrato ancora strazio e morte.
Non mi soffermerò sulla tragica scansione con cui si è modulato questo attacco. Sono sicura che ogni particolare sarà rievocato in altre parti di questo giornale. Il mio tassello sarà, come ho già detto, personale.
Sono a casa. Con mio marito stiamo pigramente progettando un incontro con amici dalle parti di Villa Borghese. Fabio, il mio figlio maggiore, studente universitario, è andato al Tempio con la sua ragazza. È napoletana e non ebrea Lucia, si trova a Roma per un giorno e il progetto di una visita al Tempio durante una cerimonia dedicata ai bambini l’attrae. Anzi, qualcosa di più.
Suona il telefono. Strano. È Lucia. Mi sta dicendo con voce quasi tranquilla che sarebbe meglio che li raggiungessimo in ospedale. “In ospedale? Siete caduti dal motorino?” chiedo. È il massimo che mi viene in mente tra le cose da temere. “No, è un attentato”.
Attentato? La parola rimbalza. Ha perso ogni significato. Non so cosa dire. “In quale ospedale siete” è l’unica frase legata alla realtà che riesco a formulare.
Dario, il mio figlio più piccolo, tornato da scuola, trova la casa vuota. Ma la cosa che lo spaventa sono le borse della spesa lasciate per terra.
L’ospedale è un altro. In quello che mi aveva indicato Lucia non c’era più posto. I feriti non gravi li hanno spostati, ma non si trovano. Non c’è nessuno che ci possa rispondere. Mi ferma una donna scarmigliata. Mi ha in qualche modo riconosciuta, ci chiede di aiutarla a rintracciare suo marito. L’istinto sarebbe quello di gridare: “Lasciaci in pace! Non sto trovando neanche mio figlio!”. Ma non si può. Mio marito ed io, seppur con altre modalità, facciamo parte della struttura comunitaria ebraica. L’imperativo non tradire il ruolo è già scattato per conto proprio. Ci affianchiamo a questa signora e cerchiamo tutti insieme.
Li abbiamo trovati. I due ragazzi sono stesi su delle barelle uno accanto all’altra, anche se sofferenti, sono riusciti a tenersi per mano. I medici dicono che le loro gambe e piedi sono lacerati da decine di schegge. Ad un certo punto decidono di ingessare la gamba, ma solo a Lucia. Prima era sembrato che fosse meno grave, per questo era stata lei ad avere il permesso di telefonarci. Ingessarla, si saprà poi, è stato un errore medico. Ma questa è una storia del dopo.
Comunque l’ospedale è troppo affollato. I feriti non particolarmente gravi possono esser trasportati a casa. Lucia non abita a Roma. Casa sua “intanto” sarà a casa nostra.
Da qui diventerà storia privata. La madre di Lucia, arrivata sconvolta da Napoli, non riuscirà a portar via con sé sua figlia. I due ragazzi hanno vissuto uniti un’esperienza sconvolgente. S’impuntano con tutte le forze. Non accetteranno di essere separati. Lucia resterà ancora a casa nostra e dopo qualche mese, seppur così giovani, i due ragazzi si sposeranno.
Ma sempre qui a casa nostra era cominciata anche quella che possiamo chiamare “parte pubblica”. Noi eravamo dei giornalisti amici e conoscenti di tanti colleghi, due giovani feriti erano adagiati nei nostri letti, è stato così che casa nostra è stata sommersa da un flusso di persone che non riuscivamo più ad arginare. Interviste, fotografie, richiesta di chiarimenti storico-politici. Letteralmente ogni angolo delle nostre stanze era occupato da un nugolo crescente di persone (ricordo la volta in cui ho dovuto dialogare con un reporter in cucina). Ma non si trattava di colore, in sostanza era tutto politico quello che accadeva lì dentro. Molti professionisti erano sconvolti quasi come noi.