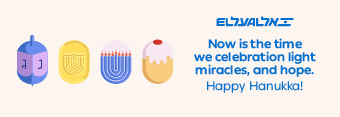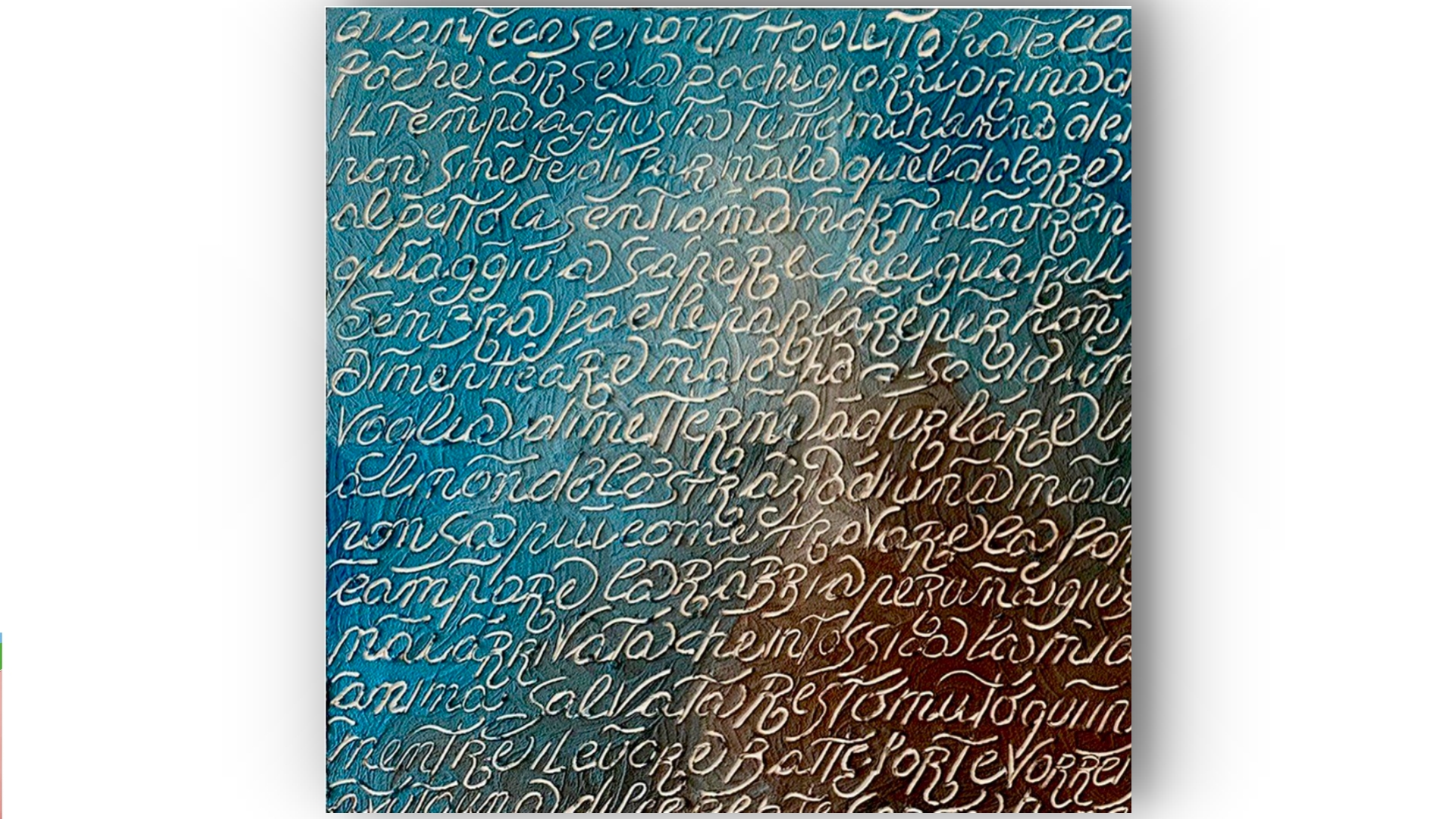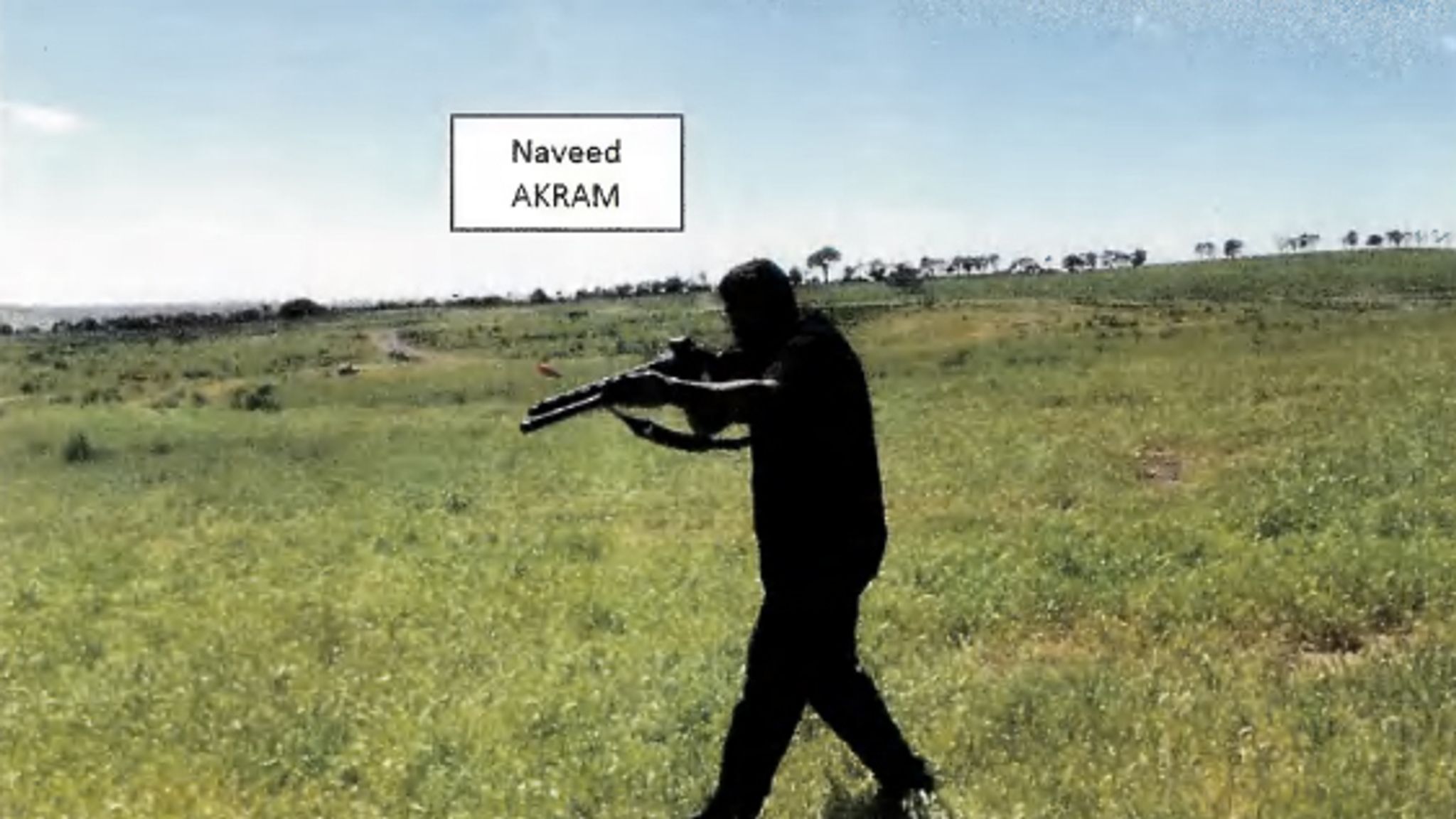L’attentato del 9 ottobre 1982 alla Sinagoga di Roma ha avuto delle forti ripercussioni anche sulle generazioni successive, in particolare sui figli dei sopravvissuti. Tra i più giovani emerge una diversa percezione di quanto accaduto. «Seppi di mio padre quando ero piccolo, ed ogni anno ho approfondito maggiormente. Lui è sempre stato riservato su questo tema, sebbene ce ne abbia parlato più volte – spiega a Shalom Beniamino Carucci, figlio del rabbino Benedetto Carucci – Sapere che abbia rischiato la vita mi fa tutt’oggi rabbrividire». Il dolore provato in prima persona è difficile da trasmettere; ma spesso sono anche piccoli gesti o semplici silenzi che possono comunicare sensazioni e insegnamenti. «La storia di mio padre mi ha cambiato la vita, incentivandomi nell’attivismo giovanile ebraico. Il mio interesse verso l’impegno comunitario non è tanto frutto dell’essere figlio di rabbino, quanto più di ciò che mio padre ha subìto».
Gino Moscati, invece, era a casa quando ricevette la tragica notizia da un amico in lacrime. «Non capii più niente, presi il motorino ed andai in Piazza – ricorda Moscati – Lungo Via XX settembre mi accorsi che molti correligionari si stavano dirigendo verso il Tempio Maggiore». I suoi genitori e la nonna furono feriti durante l’attentato. «Per diverso tempo ho vissuto con l’angoscia di non essere lì, per molte notti ho sognato come potesse essere accaduto l’attentato». Il non essere stato fisicamente presente quella mattina ad aiutare i propri cari è un senso di colpa che ha smosso, e smuove tuttora, la coscienza di Gino Moscati. «Dopo l’attentato ho sentito la necessità di darmi da fare nelle nostre istituzioni. Ho cercato nella mia vita, e sto cercando ancora oggi, di dare il mio contributo per la nostra Comunità».
L’impotenza di fronte alla tragedia è una sensazione comune fra i figli dei feriti. Così anche per Vito Anav, che all’epoca si trovava in Israele dove prestava servizio nell’esercito. La telefonata del padre lo scosse. «Non capii perché mio padre mi chiamasse in un giorno di festa. All’epoca ero impegnato sotto le armi per difendere Israele dai terroristi, ma quella mattina gli stessi mi colpirono alle spalle, in casa mia». Un insieme di emozioni contrastanti e molto forti quelle vissute da Vito Anav. «Non ho potuto proteggere la mia famiglia e la mia comunità». Tramandare quanto successo e lottare affinché non accada mai più è diventato per lui un imperativo morale. «Ogni ebreo deve essere autore della propria difesa e del proprio destino».
Baruch Sermoneta, che si trovava al Tempio con Max Shamgar, direttore del Keren Kayemet a Roma, venne ferito e portato in ospedale. Suo figlio Hillel, all’epoca in Israele, ricevette la notizia dal padre in piena notte. La notizia ebbe un grande risalto anche nello Stato Ebraico. Il mattino seguente fu intervistato dal quotidiano Maariv e venne a conoscenza di un incontro tra i rappresentanti del Tempio italiano e alcuni rappresentanti della Knesset per parlare di quanto successo il giorno prima. «In Israele molte famiglie hanno vissuto un trauma come il nostro, se non addirittura più grande – sottolinea Hillel Sermoneta – Penso che bisogna andare avanti e ringraziare Dio che mio padre sia rimasto in vita quel giorno. Tuttavia è altresì importante tramandare ai miei figli quanto accaduto e ricordare sempre che bisogna rimanere sempre vigili, perché c’è sempre qualcuno che vuole distruggerci».
Quanto accadde quel giorno ha di fatto cambiato la vita di molte persone. Come è successo a Riccardo Pacifici, che appena diciottenne si ritrovò nel ruolo di capofamiglia. Il padre, Emanuele Pacifici, fu gravemente ferito quel tragico 9 ottobre, tanto da essere considerato deceduto e coperto col lenzuolo bianco. «Quando il professor Toaff arrivò nella camera mortuaria, recitò i salmi per Stefano Gaj Tachè e poi per mio padre, quando si accorse che si stava muovendo. Cominciò a strillare per chiamare i medici, che gli salvarono la vita». Quel sabato mattina anche Riccardo Pacifici era rimasto a casa. Poi la telefonata dalla guardiola del Tempio. «Mio cugino mi raccontò quanto accaduto e poi mi rassicurò che mio padre non ci fosse perché era andato via. In effetti l’agenda di mio padre diceva che lui avesse un appuntamento di lavoro verso mezzogiorno». La corsa verso l’ospedale per assistere i feriti, ancora ignaro della realtà, fin quando un amico di famiglia non lo mise al corrente di tutto. «Seppi che, prima di mandarlo in sala operatoria, il dottor Schirilò ordinò di fargli una tracheotomia perché il sangue stava scendendo nei polmoni. Mi dissero che mio padre era in grave pericolo di vita e che forse non avrebbe superato la notte: il mondo mi è crollato addosso». Ma non andò così. Emanuele Pacifici venne salvato, sebbene portò a lungo con sé i danni dell’attentato. Appena sveglio chiese un paio d’occhiali ed un libro dei salmi, comunicando per tanto tempo con dei bigliettini. Eventi come questi cambiano per sempre la vita non solo dei testimoni diretti, ma anche di chi li circonda. Dopo questa esperienza, infatti, Riccardo Pacifici ha partecipato con grande dedizione alle attività ebraiche, prima nel Movimento Culturale Studenti Ebrei, poi come consigliere ed infine come presidente della Comunità ebraica romana. Con un sogno che oggi è realtà: costruire un tempio dove accogliere tanti giovani e bambini, per farli crescere nell’ebraismo. «Oggi è realtà, abbiamo costruito un tempio intitolato a Stefano Gaj Tachè: il Bet Michael. È la risposta ebraica a chi pensava di dividerci e annientarci».