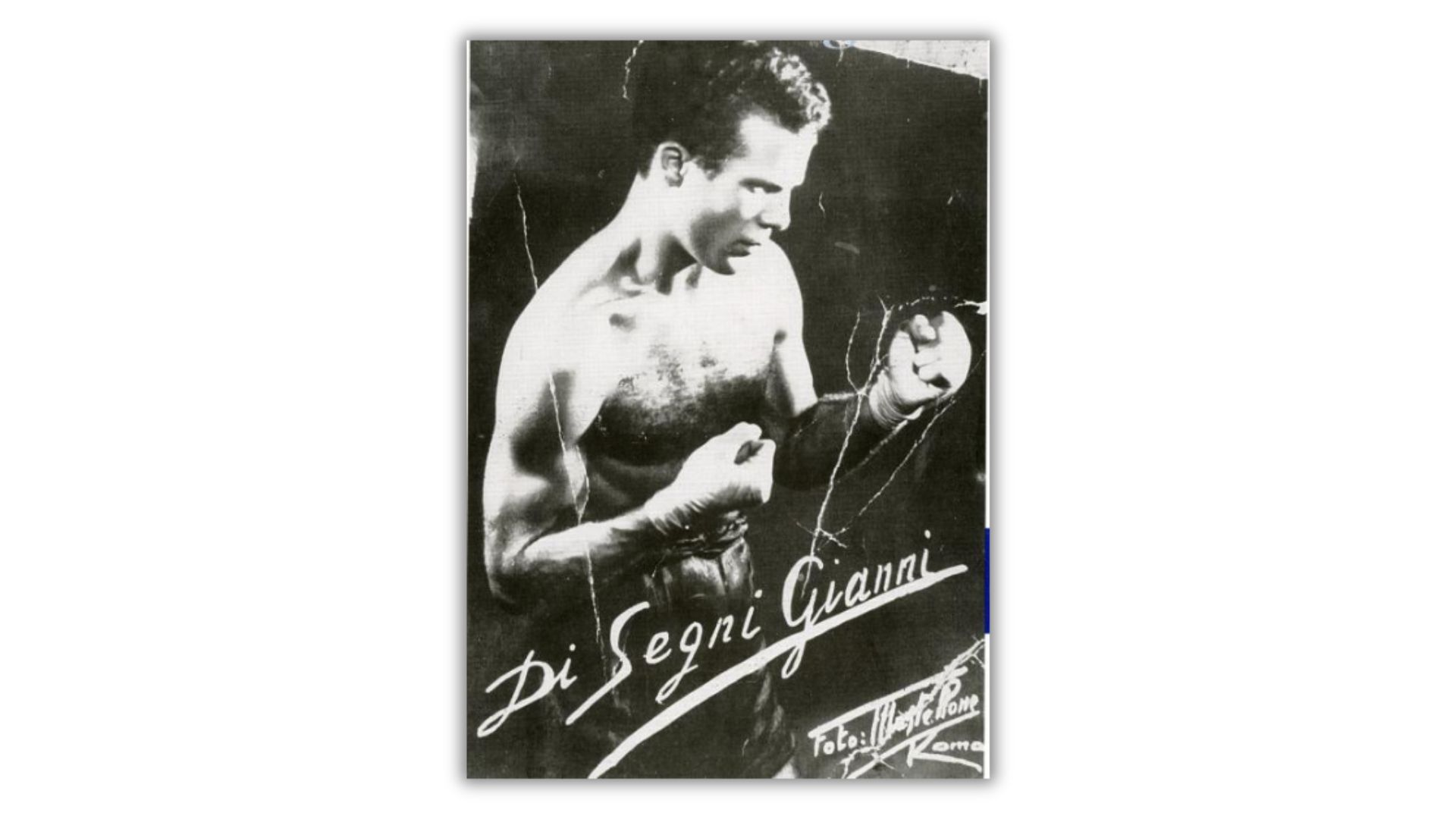Per giorni, una foto straziante ha fatto il giro del mondo: un bambino palestinese, visibilmente debilitato, tenuto in braccio da sua madre. L’immagine era stata pubblicata in prima pagina dal New York Times, accompagnata da un’accusa implicita ma potente: Israele affama i bambini di Gaza. Nessuna precisazione, nessun contesto medico. Solo un’immagine pensata per colpire allo stomaco dell’opinione pubblica.
Ma quella storia era falsa.
Nei giorni successivi, è emerso che il bambino in questione – di nome Muhammad – non stava morendo di fame. Soffriva di una grave condizione neurologica congenita: paralisi cerebrale. A confermarlo non è stata una smentita israeliana, ma il New York Times stesso, costretto a pubblicare una correzione. Una precisazione tardiva, pubblicata in piccolo, letta da poche migliaia di utenti, a fronte dei milioni che avevano visto la versione originale.
“Troppo poco, troppo tardi”, ha tuonato l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, in un video pubblicato sul suo profilo X. “Il danno è stato fatto. L’accusa è stata lanciata, la demonizzazione di Israele portata a termine”, ha detto.
Leiter ha anche denunciato una manipolazione deliberata dell’immagine: nella foto originale c’era anche il fratello di Muhammad, un bambino visibilmente sano. Ma il New York Times avrebbe ritagliato l’immagine per eliminare ogni elemento che potesse contraddire la narrazione del bambino affamato da Israele.
Un caso di propaganda ben orchestrata?
Secondo l’ambasciatore, sì. “Siamo di fronte a una campagna ben finanziata per demonizzare Israele e il popolo ebraico”, ha detto. E ha paragonato il clima attuale a quello della “panico satanico” degli anni ’80, ma con una differenza: “Ora Israele è dipinto come Satana”.
L’appello finale di Leiter è chiaro: “Non accettate la propaganda dei media tradizionali. Cercate la verità. Chiedeteci e vi manderemo le informazioni vere, che non troverete sul New York Times”.
Un incidente isolato? O un modello ricorrente?
Il caso del piccolo Muhammad non è il primo. In tempi di guerra, la corsa alla notizia “emotiva” spesso prevale sulla verifica dei fatti. Ma quando anche il quotidiano più prestigioso del mondo cade in queste trappole narrative, la domanda diventa inevitabile: quanto possiamo davvero fidarci di un’informazione che troppo spesso trasforma Israele nel colpevole designato?
E soprattutto: chi ripagherà il danno morale e politico, già inflitto a uno Stato che da mesi lotta non solo contro il terrorismo di Hamas, ma anche contro una macchina mediatica pronta a demonizzarlo a ogni costo?