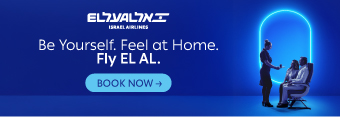Il 16 ottobre 1943 è una data indimenticabile per gli ebrei di Roma. Quel piovoso sabato mattina in cui i soldati tedeschi deportarono gli ebrei capitolini in direzione Auschwitz ha cambiato per sempre la vita di tutti: sia dei testimoni diretti che dei loro discendenti. Perché, fra le sue drammaticità, la Shoah ha provocato anche dei traumi generazionali. Traumi fatti di rabbia, incomprensione, di gesti o pensieri che originano proprio dagli atteggiamenti dei nonni, come se il dolore fosse in grado di permeare le barriere del tempo.
Quel nefasto giorno d’ottobre, Angelo Efrati venne catturato nella propria casa a Via di Portonaccio. Quando tornò, incredibilmente assieme al fratello, non fu più lo stesso. Prima la depressione e poi la collera lo cambiarono, tanto da testimoniare le atrocità vissute una sola volta e basta. «Non ha mai parlato in famiglia – spiega il nipote, Edoardo – Ci raccontò solo di quando venne riempito di bastonate. La Shoah lo aveva trasformato, purtroppo portava con sé una rabbia fuori dal normale. Era l’uomo più buono del mondo, ma bastava poco per accenderlo in maniera importante. Quel dolore è arrivato fino a noi: mio padre il 16 ottobre digiuna, io invece credo di aver mutato quel sentimento in un attaccamento molto forte all’ebraismo».
L’amplificazione dei sentimenti è uno degli “effetti collaterali” più comuni tra i nipoti della Shoah. Ma c’è anche chi, inconsapevolmente, ha sviluppato le medesime ansie dei propri nonni. Come Fabrizio Di Neris, nipote di Raimondo (catturato nell’aprile 1944), che sin da giovane non riesce a sentir piangere i bambini. «Quando li sento, penso subito alle SS che li strappano via dalle famiglie. Solo più tardi ho scoperto che mio nonno, ad Auschwitz, era stato collocato ai lavori sulla Rampa, nel punto in cui arrivavano i treni. Vedeva intere famiglie divise da quei soldati, un trauma che l’ha condizionato a tal punto che, una volta libero, non riusciva più a sentire il pianto di un bambino. Ma questo l’ho appreso solo dopo la sua morte». Ogni deportato ha vissuto la tragedia a modo proprio: chi facendo della testimonianza una missione, chi cercando di stigmatizzare il proprio dramma.
Pamela Terracina ha raccontato a Shalom la storia del nonno Davide Di Veroli (arrestato nel dicembre 1943). «Mio nonno è morto il 22 maggio 2006, lo stesso giorno che anni addietro era entrato ad Auschwitz. Fu catturato su un treno diretto a Firenze, dopo aver litigato con un uomo che aveva tentato di molestare una donna. Una persona buona, meravigliosa, amata da tutti. E poi era altruista: non ha mai testimoniato, però ha aiutato il professor Marcello Pezzetti a raccogliere le testimonianze di tutti i sopravvissuti. Si è messo in prima linea per far parlare tutti, tranne se stesso».
Ognuno dei sopravvissuti ha portato con sé dei timori. Raimondo Di Neris «a pranzo, quando gli veniva messo il piatto davanti, restava circa un minuto in tilt stringendo il piatto, poi mangiava tre-quattro forchettate di fretta e infine tornava in sé», mentre Angelo Efrati «non aveva simpatia per i pastori tedeschi. Una volta, in Piazza, c’erano delle persone vestite da SS per girare un film: mio padre mi disse di averlo visto impaurito per la prima volta in vita sua».
Il passato riflette nel presente come un riverbero di luce. Ai nipoti restano le storie dei nonni, ma soprattutto i loro insegnamenti, sempre proiettati nella bontà verso il prossimo, e il sorriso che trapela dalle loro voci quando li ricordano. «Mio nonno mi ha insegnato a essere sempre gentile con tutti – prosegue Pamela – Ma la sua storia mi ha lasciato tanta rabbia. Adoro viaggiare, però in Germania non ci riesco ad andare. Lavoro con i treni, ma rifiutai la prima volta che me lo proposero: non me la sentivo di lavorare per quei treni che per lui sono stati fatali. Poi è andata diversamente. Ho anche l’abilitazione per guidarli, e mi fa sorridere che lo dicesse a tutti con grande entusiasmo. Forse la vedeva come una rivincita sulla storia».
Queste vicende hanno cambiato anche le generazioni future. Il trascorso di Raimondo ha spinto Fabrizio a vivere in Israele, dove ha studiato in Yeshivà e dove continua a prestare servizio militare nella Guardia di frontiera come volontario. Per i sopravvissuti, la data di liberazione è stata come un seconda nascita. Per anni è stata l’appuntamento fisso per grandi cene in famiglia che tutt’oggi proseguono, anche dopo la loro scomparsa. Quel fatidico 16 ottobre, allora, è stato l’inizio di un trauma ancora vivo, anche in coloro che non hanno avuto i propri parenti deportati. Perché il dolore non è solo generazionale, ma appartiene ad un popolo intero che nel tempo ha saputo rialzarsi e costruire un futuro fatto di vita.
[GALLERY]