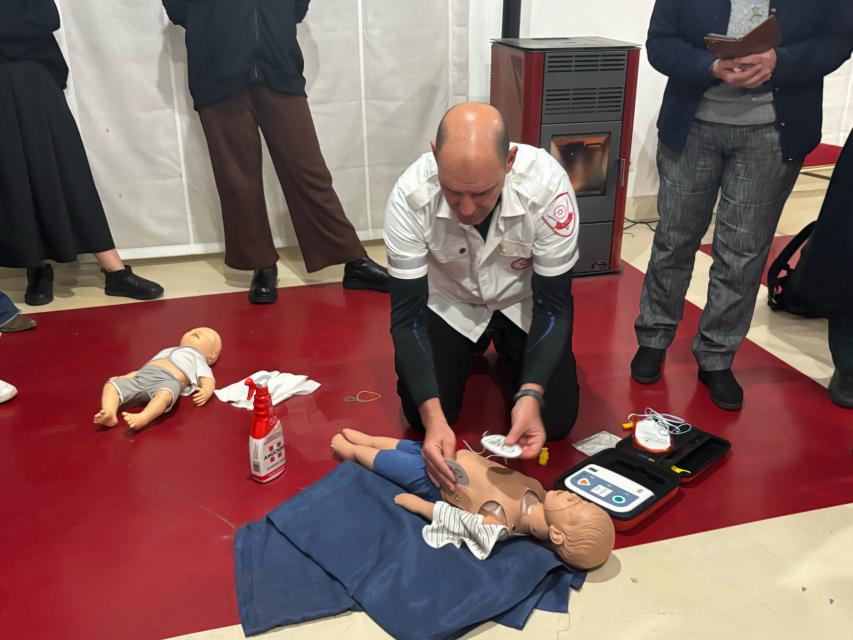Silvana Ajò oggi è una vivace novantacinquenne. Nel 1943 era invece ancora una bambina, quando ai primi di ottobre suo padre Valerio venne contattato da un amico che lavorava al Ministero dell’Interno.
Erano trascorsi pochi giorni da quando gli ebrei romani, sperando di salvarsi, avevano raccolto, grazie anche alla solidarietà anche di alcuni romani non ebrei, i 50 kg d’oro richiesti dai nazisti. Al telefono, l’amico che lavorava al Ministero gli disse che sentiva in giro voci che non gli piacevano e consigliò a Valerio di allontanarsi con la moglie e le tre figlie dalla loro casa.

«Non fu facile. Oltre a pensare a dove andare, dovevamo trovare qualcuno che rimanesse a casa nostra mentre non c’eravamo. Altrimenti sarebbe andata a persone sconosciute. Quando il capofabbricato vedeva che le case a seguito di deportazioni o fughe si liberavano, le faceva riempire da sfollati o altri inquilini. Alla fine ci andarono alcuni parenti di una commessa del negozio di mio padre».
Silvana ricorda che il padre avvertì anche gli zii della mamma Enrica, i Belleli, che abitavano a Via Salaria, vicino a Viale Liegi. I Belleli decisero di non lasciare la loro casa. «Dissero che erano anziani, che avevano sentito dire che prendevano solo i giovani e che volevano aspettare che arrivassero a Roma la figlia e la nipotina. Non se ne andarono. La mattina del 16 ottobre i tedeschi li presero tutti. Non sono più tornati».
Da alcuni anni Silvana è volontaria alla Fondazione Museo della Shoah di Roma. Qui ha incontrato un’anziana signora che le ha raccontato che viveva a Via Salaria, vicino a Viale Liegi, nello stesso palazzo dei suoi zii materni. Silvana, incuriosita, le ha chiesto che cosa fosse accaduto alle case di chi veniva deportato. «La signora, all’epoca una bambina, ricordava che i fascisti tornavano sempre. Erano italiani, non tedeschi. I fascisti approfittavano delle case vuote, prendevano oggetti di valore, adatti alla vendita, li portavano in cortile e li mettevano all’asta. Li rivendevano. I palazzi avevano un grande cortile in mezzo e scale intorno. Così si radunava un po’ di gente per vedere gli oggetti raccolti dalle case dei deportati o di chi si era nascosto e che venivano venduti all’asta».

Dopo la guerra la famiglia Ajò tornò nella propria abitazione di Via Agri. «Non riuscivamo a rientrare perché la famiglia a cui l’avevamo affidata non se ne andava più. Non hanno portato via niente da casa nostra ma ormai la consideravano loro. Era diventata la loro casa. Alla fine mio padre, non riuscendo a rientrarne in possesso dovette pagarli».
Furono molte le famiglie ebraiche romane che dopo la guerra non riuscirono a rientrare facilmente
in possesso delle proprie case, dei propri negozi, dei propri beni immobiliari. La persecuzione patrimoniale è stato un tassello fondamentale delle leggi razziali del 1938.
Quando le famiglie lasciavano le loro abitazioni per nascondersi o perché deportate, portavano con sé piccoli oggetti di valore, del cibo e quanto necessario per l’igiene personale. Erano i piccoli bagagli sicuramente quasi uguali a quelli che milioni di altri ebrei in Europa avevano già preparato prima di loro. Già nel 1939 il fascismo aveva costituito l’EGELI, l’Ente si doveva occupare della liquidazione dei beni immobiliari e delle aziende confiscate ai cosiddetti nemici della Patria e agli ebrei, colpiti dalle leggi razziali.
Il destino dei tanti beni rimasti dentro quelle case abbandonate in attesa di un ritorno che in molti casi non ci fu, è inevitabilmente passato in secondo piano rispetto alla vicenda umana dei proprietari. Ma proprio le storie di mobili, quadri, gioielli, vestiti, oggetti con un valore materiale o affettivo rappresentano una pagina della storia del nostro Paese: una storia caratterizzata dal collaborazionismo fascista pronto a supportare i nazisti e ad approfittarsi della tragedia in corso e dall’atteggiamento indifferente e opportunista di quegli italiani che preferirono girarsi dall’altra parte e giovarsi della situazione.

Photo credits: Fondazione Museo della Shoah, Roma Fondo Silvana Ajò Cagli